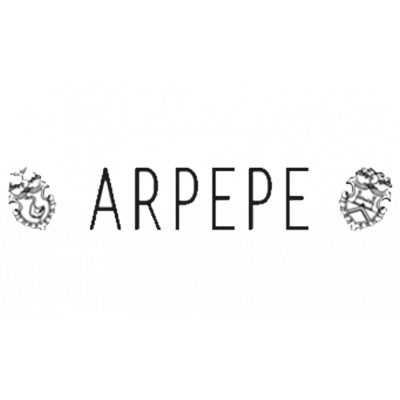Il piccolo “diavolo rosso” che ha conquistato il mondo (e che fa pure bene)

Una storia che inizia molto lontano
C’è una storia che merita di essere raccontata, una storia che inizia 7.000 anni fa quando un abitante di quello che poi sarebbe stato chiamato il “Nuovo Mondo” ha forse inconsapevolmente assaggiato un frutto che probabilmente gli ha regalato sensazioni mai provate prima: un calore piacevole, una piccantezza che invece di allontanarlo lo ha affascinato, trasformando per sempre il modo di cucinare e di gustare il cibo.
I reperti archeologici di Tehuacán in Messico e Guitarrero in Perù ci raccontano che già 5.000 anni prima di Cristo si coltivavano peperoncini con la stessa cura che noi oggi dedichiamo alle piante più preziose. Le grandi civiltà precolombiane – Maya, Aztechi, Inca – non si limitavano a mangiarli, bensì li usavano come moneta corrente. Immaginate la considerazione che avevano per questi piccoli frutti rossi se li ritenevano preziosi quanto l’oro che tanto avrebbe affascinato gli europei.
Le testimonianze che ci hanno lasciato sono straordinarie. L’obelisco di Tello, in Perù, mostra un drago mitologico con quattro peperoncini tra le fauci, i ricami di Nazca raffigurano contadini con peperoncini al collo come gioielli. E poi c’è Cerèn, il villaggio Maya, situato nell’attuale El Salvador, sepolto dalla lava nel 595 d.C. – una sorta di Pompei americana dove gli archeologi hanno trovato peperoncini in ogni casa, essiccati, conservati, usati come medicina e perfino abbinati al cioccolato. Era chiaramente molto più di un semplice condimento: faceva parte della loro identità culturale.
Colombo e il business plan che non funzionò
Arriviamo al 1493, quando Cristoforo Colombo scrive nelle sue relazioni di aver trovato “axi che è il loro pepe, di qualità che molto sopravanza quella del pepe e non v’è chi mangi senza di esso che reputano assai curativo”. Il navigatore genovese aveva fiutato l’affare commerciale: nel secondo viaggio del 1494, insieme al medico di bordo Diego Alvarez Chanca, avvia le prime coltivazioni per i Reali di Spagna.
L’idea sembrava geniale: creare il monopolio di questa nuova spezia piccante che avrebbe dovuto rivaleggiare con il costosissimo pepe orientale. Il piano, sulla carta, era perfetto. Nella realtà si rivelò uno dei più clamorosi fallimenti commerciali dell’epoca.
Tre ragioni per un insuccesso che divenne conquista
Il business dei Reali di Spagna naufragò per tre motivi che, oggi, ci fanno sorridere. I ricchi e i nobili dell’epoca lo trovavano troppo piccante per i loro palati raffinati – erano abituati a sapori più delicati e controllati. La pianta si rivelò facilissima da coltivare, cresceva anche in un semplice vaso sul davanzale: addio sogni di monopolio commerciale. E poi c’era la Chiesa, che lo disapprovava apertamente: il gesuita José de Acosta lo bollò come “suscitatore di insani propositi”, temendo che stimolasse eccessivamente i sensi e portasse a comportamenti poco consoni.
Mentre l’aristocrazia europea lo rifiutava, accadeva qualcosa di inaspettato: il popolo se ne stava innamorando perdutamente. La diffusione fu rapidissima e inarrestabile. In appena sessant’anni, come testimoniano gli scritti di Bartolomé de Las Casas del 1552, era già presente in tutta la Spagna. Da lì si diffonde nell’Europa intera, tanto che nel 1568 il botanico senese Pier Andrea Mattioli lo descrive nei suoi trattati chiamandolo “pepe d’India” – perché nessuno aveva ancora chiarito completamente le sue vere origini geografiche.
Secoli dopo, nella Calabria dell’Ottocento, il peperoncino era diventato il “lardo della povera gente”, tanto prezioso da essere usato letteralmente come moneta di scambio. Lo scrittore Vincenzo Padula documenta una realtà in cui la gente veniva “pagata con fichi di scarto e peparoli”.
Il tesoro che cresceva dietro casa
La cosa affascinante di questa storia è il ribaltamento di prospettiva che ne emerge. Mentre i ricchi spendevano fortune per procurarsi spezie esotiche dall’Oriente, i contadini del Sud Europa e del Mediterraneo avevano scoperto, quasi per caso, quello che oggi chiameremmo un vero “superfood”. Il peperoncino dava sapore intenso ai cibi più semplici, conservava la carne quando non esistevano frigoriferi, disinfettava naturalmente grazie alle sue proprietà antibatteriche, e sembrava avere funzione di vero e proprio toccasana per la salute in generale.
Questa scoperta trasformò intere culture culinarie. I Messicani ci insaporivano le tortillas, gli Africani la manioca, gli Asiatici lo integrarono nelle loro cucine tradizionali. Le regioni meridionali italiane, soprattutto la Calabria, riuscirono a trasformare quella che era considerata “cucina povera” in una tradizione gastronomica ricca di carattere e personalità, creando quelli che oggi riconosciamo come autentici capolavori del gusto.
Un frutto, mille nomi
La storia dei nomi di questo piccolo frutto riflette la confusione geografica e culturale dell’epoca. Dagli indigeni americani era chiamato “axi“, termine che Colombo riporta fedelmente nei suoi diari. In Europa assume una serie di denominazioni che riflettono i tentativi di classificarlo: “pepe d’India“, “pepe cornuto“, “siliquastro“. Solo nel Seicento inizia ad affermarsi il nome scientifico “Capsicum“, che finalmente lo identifica in modo univoco.
Il poeta satirico Niccolò Forteguerri di Pistoia, vissuto tra il 1674 e il 1755, è il primo a usare il termine “peperone” – una parola derivata dal piemontese “pevrum” e dai dialetti ligure-lombardo-emiliani “pevron”. Il diminutivo “peperoncino” è molto più recente: compare solo alla fine del 1800. In pratica, sono serviti quasi tre secoli per mettersi d’accordo su come chiamarlo, un tempo che oggi ci sembra infinito, abituati come siamo a vedere neologismi e anglicismi entrare nel vocabolario nell’arco di pochi anni, se non addirittura di stagioni. Pensiamo a quante parole legate al digitale sono diventate di uso comune in pochissimo tempo, mentre il povero peperoncino ha dovuto aspettare secoli per avere un nome definitivo.
Da “roba da poveri” a farmaco naturale
Il vero colpo di scena di questa storia arriva nel XX secolo, quando la ricerca scientifica ribalta completamente la percezione del peperoncino. Quello che per secoli era stato considerato “cibo da poveri”, qualcosa di volgare e poco raffinato, viene improvvisamente riconosciuto come un vero farmaco naturale.
La capsaicina, quella sostanza che provoca la caratteristica sensazione di bruciore, si rivela essere un potente vasodilatatore. Significa che mentre voi avvertite quella sensazione di calore in bocca, i vostri vasi sanguigni si stanno rilassando e la pressione arteriosa sta diminuendo. È come se la natura avesse nascosto un portentoso medicinale dentro un condimento.
Le scoperte non finiscono qui. Il peperoncino contiene sei volte più vitamina C di un’arancia ed è ricchissimo di antiossidanti come carotenoidi, zeaxantina e criptoxantina, sostanze che combattono i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare. Una curiosità che sorprende molti: i semi del peperoncino non sono piccanti di per sé, ma assorbono la capsaicina dalla placenta, quella struttura bianca e spugnosa in cui sono immersi.
Il mistero del piacere che brucia
Una delle scoperte più affascinanti riguarda la natura stessa del piccante. Quello che chiamiamo “sapore piccante” tecnicamente non è un sapore: non coinvolge le papille gustative che riconoscono dolce, salato, acido, amaro e umami. Il piccante attiva i nervi del trigemino, gli stessi che ci trasmettono la sensazione di dolore. È per questo che animali e bambini istintivamente lo rifiutano: il loro istinto di sopravvivenza funziona perfettamente.
Noi adulti, invece, sviluppiamo questo gusto apparentemente masochistico per una ragione biochimica precisa. Mangiare piccante stimola la produzione di endorfine, gli oppiacei naturali del nostro cervello. In pratica, il peperoncino attiva lo stesso meccanismo di benessere che si innesca durante l’attività fisica intensa o l’innamoramento. Il risultato è una sensazione di euforia dolce e naturale che crea una vera e propria dipendenza positiva.
La scala scientifica del “bruciore”
Nel 1912 il farmacista americano Wilbur Scoville decide di mettere ordine in questa materia inventando un sistema di misurazione che porta il suo nome: le Scoville Heat Units. L’idea era semplice quanto geniale: quantificare scientificamente quanto un peperoncino “faccia male”. Il metodo originale aveva un che di artigianale: prevedeva di diluire estratti di peperoncino in acqua zuccherata fino a quando il piccante non fosse più percepibile da un panel di assaggiatori. Oggi la misurazione avviene attraverso la cromatografia liquida ad alte prestazioni, un metodo molto più preciso e obiettivo delle papille gustative umane.
La scala parte da 0, il punteggio del dolce peperone da insalata, e arriva ai 2.200.000 punti del Carolina Reaper, attualmente riconosciuto come il peperoncino più piccante al mondo. Ma c’è chi sta lavorando per battere questo record: il Pepper X, sviluppato dallo stesso coltivatore del Carolina Reaper, dovrebbe superare i 3 milioni di unità Scoville, anche se attualmente si trova ancora in fase di certificazione ufficiale.
In questo panorama di estremismi, il nostro peperoncino calabrese, con i suoi 50.000-100.000 punti Scoville, rappresenta quello che si potrebbe definire l’equilibrio perfetto: abbastanza caratteristico da essere interessante, abbastanza gentile da rimanere godibile anche per chi non ha il palato allenato agli eccessi.
Il successo mondiale di oggi
La storia del peperoncino è anche la storia di una rivalsa sociale che continua ancora oggi. Quel frutto che l’aristocrazia europea rifiutava è diventato il secondo condimento più utilizzato al mondo dopo il sale marino. L’Ungheria guida la classifica mondiale dei consumi con la sua tradizionale paprika dolce, mentre Francia e Spagna possono vantare gli unici peperoncini europei con marchio di qualità DOP: il Peperoncino di Espelette francese e il Pimiento del piquillo spagnolo.
C’è un dettaglio che racconta molto sui pregiudizi dell’epoca: Pellegrino Artusi, l’autore che nel 1891 codificò la cucina nazionale italiana con il suo celebre trattato “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, non cita mai il peperoncino tra le sue ricette. Per i palati borghesi dell’Italia post-unitaria era evidentemente ancora troppo “popolare”, troppo legato alla tradizione contadina.
Eppure, già nel XVIII secolo, quando Napoli era considerata una delle capitali gastronomiche d’Europa, cuochi raffinati come Vincenzo Corrado di Oria stavano sperimentando ricette elaborate come il “Peperoncino in addobbata”, una preparazione complessa utilizzata per farcire le teste di capretto. Era già alta cucina, ma doveva ancora essere riconosciuta come tale.
Il vero debutto ufficiale del peperoncino nell’alta gastronomia italiana arriva solo nel 1931, in un contesto quanto mai particolare: il primo pranzo futurista organizzato da Filippo Tommaso Marinetti. Il menù prevedeva un antipasto rivoluzionario fatto di peperoncini verdi all’interno dei quali erano nascosti bigliettini con slogan propagandistici. L’arte d’avanguardia incontra la tradizione culinaria e la trasforma in manifesto culturale.
Un piccolo tesoro che continua a sorprendere
Ogni volta che aggiungete peperoncino ai vostri piatti state partecipando, consapevolmente o no, a una tradizione che attraversa millenni di storia umana. State assaporando lo stesso frutto che i Maya consideravano tanto prezioso da trasformarlo in moneta corrente, che Cristoforo Colombo pensava di poter monopolizzare per arricchire la corona spagnola, che la Chiesa cattolica temeva per i suoi effetti sulla moralità, e che le classi popolari di mezzo mondo hanno sempre saputo essere un vero tesoro nascosto.
La storia del peperoncino è la storia di una conquista dal basso, di un ingrediente che è riuscito a imporsi partendo dalle tavole più umili per arrivare fino ai ristoranti stellati, ignorato dai potenti ma amato da chi sapeva riconoscerne il valore autentico. È una lezione di umiltà che vale ancora oggi, in un mondo dove spesso confondiamo il prezzo con il valore e la moda con la sostanza.
Se questa lunga storia vi ha incuriosito abbastanza da voler sperimentare personalmente con questo piccolo protagonista della gastronomia mondiale, noi di Ghusto abbiamo selezionato una deliziosa Crema di peperoncino. Dopo aver scoperto che questo ingrediente ha radici più antiche della civiltà occidentale e proprietà benefiche riconosciute dalla ricerca scientifica moderna, merita di essere assaggiato e apprezzato nella sua forma più raffinata. Non promettiamo trasformazioni miracolose, ma possiamo garantire che la vostra cucina guadagnerà sicuramente in personalità, carattere e autenticità.
Crema di peperoncino
Un condimento piccante e cremoso ottenuto da peperoncini tritati, olio d’oliva e aromi, ideale per esaltare il gusto in cucina
10 disponibili